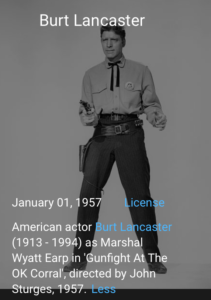Si arriva sempre in un posto nuovo con il proprio bagaglio e riflessi culturali. Dominica è un paese molto religioso, cristiano prevalentemente protestante, con minoranze evangeliche ma anche cattoliche. Infatti per l’emergenza in proporzione alla dimensione del paese si sono ritrovate molte ONG con forte connotazione religiosa da quelle cristiane occidentali, ai testimoni di Geova fino a un ONG israeliana molto attiva. Manca all’appello un’organizzazione musulmana malgrado ci sia una comunità islamica abbastante importante. Quindi per natale e capodanno mi aspettavo grandi festeggiamenti. Grande delusione invece! Da buon paese cristiano il natale di Cristo si festeggia con messa di mezzanotte, giornata in famiglia, pochi regali e qualche fuoco di artificio. Il capodanno zero! Un giorno qualsiasi dell’anno. Si va a dormire come di consueto alle dieci di sera (come in tanti paesi tropicali dove fa buio alle sei ci si sveglia presto e si va a letto presto). Capodanno esiste solo perché segna l’avvicinarsi del vero, atteso evento annuale: il Carnevale. Che si comincia a festeggiare un mese prima quindi già a gennaio. Però in Dominica nulla è proprio “normale”.
Un venerdì vado tranquillo verso mezzanotte quando in piena notte vengo svegliato da musica da discoteca a tutto volume tanto da far sembrare che la musica venga dalla casa a fianco alla mia stanza. Sono le quattro del mattino e mi affaccio al balcone. Vedo gente per strada che fa la fila per entrare in un locale dall’altra parte del campo di calcio che sta al lato della palazzina dove vivo. La festa va avanti fino alle sei e poi smette. Il giorno seguendo mi dicono che per un mese fino a carnevale ci saranno feste, quasi un allenamento per arrivare preparati al grande Evento. E ci prepara dalle quattro alle sei del mattino con musica sparata a migliaia di decibel che si espande in tutto il quartiere. Le serate successive, visto che era impossibile dormire, decido di partecipare e vederlo dal vivo. La serata è un deejay che suona cover cantandoci sopra, arrangiando musica disco ma senza trascinare veramente il pubblico a ballare che infatti balla poco. La musica ad alto volume è comunque una tradizione di Dominica. Generalmente sparata da casse mostruose montate nei bagagliai delle macchine. I venerdì sera, unico vero giorno di festa della settimana, tutti i giovani dell’isola si riversano nella capitale girando più volte in macchina per le due strade principali con musica a tutto volume, facendo concorrenza con i decibel dei tre locali principali con le casse rivolte in strada. Un’accozzaglia di suoni annaffiata da rum artigianale.
La preparazione verso il grande evento prevede anche un festival della canzone, che ho la possibilità di seguire dal vivo, visto che si svolge sul campo di calcio vicino casa. Ogni sabato per quasi due mesi una sessantina di concorrenti si affrontano fino ad arrivare a una selezione dei dieci migliori per la grande finale. È il Calypso, un vero e proprio Sanremo della Dominica. I cantanti devono presentare inediti e vengono valutati da una giura di specialisti, in base al testo, la musica e la presentazione artistica. Per un mese le radio passano a ripetizioni le nuove canzoni, trasmissioni intere ne fanno la critica, prevedono finalisti e vincitore, tutti ne parlano per strada facendo il tifo e aspettando la finale. Che si svolge il sabato prima del giovedì grasso dalle sette a mezzanotte, quest’anno sotto una pioggia ininterrotta tanto che il pubblico immobile affonda nel fango. Nessuno balla perché alla fine la parte più importante è il testo. La musica va in secondo piano e tutti ascoltano attentamente i testi a volte ironici, a volte di denuncia politica. In un paese cosi piccolo dove tutti si conoscono, dove il primo ministro conosce per nome tutti, la loro vita (e la loro preferenza politica), il Calypso diventa l’espressione politica di opposizione e di denuncia più importante. Quest’anno il tema ricorrente era ovviamente Maria e come venissero spesi i soldi degli aiuti e della ricostruzione. Quest’anno the King of Calypso è stato Bobb con una canzone-denuncia sulla libertà di espressione del Calypso. Buon musicista Bobb, eclettico, che ho conosciuto perché ha fotografato i nostri eventi, è riuscito a vincere dopo tanti tentativi. E’ diventato personaggio dominicano dell’anno.
Finito il Calypso, arriva finalmente il Carnevale. La giornata clou è il martedì grasso. Però i festeggiamenti cominciano già il lunedì, ovviamente alle 4 del mattino. Concerto a tutto volume, stessa musica, stesso schema delle feste preparatorie con deejay che suona cover e canta. Però questa volta non ci si ferma alle sei del mattino ma si va ad oltranza. Il perfetto partecipante del Carnevale ci arriva preparato, molto idratato, abbigliamento da festa, scarpe da fango e soprattutto zainetto tipo ultra-marathoner con porta liquido incorporato e tubicino per un’idratazione continua, acqua o rum che sia. Per due giorni, entrambi festa nazionale, tutta l’isola viene travolta da un turbinio di gente che avanza in una processione con musica a tutto volume procedendo in un unico movimento in piccoli passi uno-due, uno-due a ritmo di Suka. Il Suka, il ballo dal richiamo sessuale esplicito. La dama si pone davanti al suo cavaliere porgendo il proprio fondo schiena ben appoggiato alla zona inguinale maschile. La dama poi fa scendere lentamente il suo busto fino a novanta gradi, mentre il cavaliere rimane inerme (e per quanto possibile impassibile). E avanzano, uno-due, uno-due. La dama può rimanere con lo stesso cavaliere oppure scegliere di appoggiare il suo fondo schiena contro un altro cavaliere. Cosi come il cavaliere può scegliere di offrire il proprio inguine a un’altra dama. E cosi via uno-due, uno-due, tutto il giorno in un turbinio di gente, sotto la pioggia battente o sotto il sole cocente fino a notte. Il martedì, giornata finale, si ricomincia solo che questa volta con la parata dei carri e la ricchezza dei travestimenti. E un tasso alcolico molto più alto. Tutto sommato, malgrado musica e alcol inebrianti il grande ballo di massa si svolge senza grandi incidenti. Al minimo segnale di violenza, la processione e la musica vengono fermati finché ritorna la calma. Tutto è permesso al Carnevale, grande valvola di sfogo dell’isola, senza gli eccessi violenti di altri paesi. Tanto che Dominica è tra i paesi meno violenti dei paesi caraibici, che contano 15 dei primi 25 paesi con il maggior numeri di morti ammazzati al mondo. Il paradiso da cartolina non è sempre cosi paradisiaco per chi ci vive tutto l’anno.